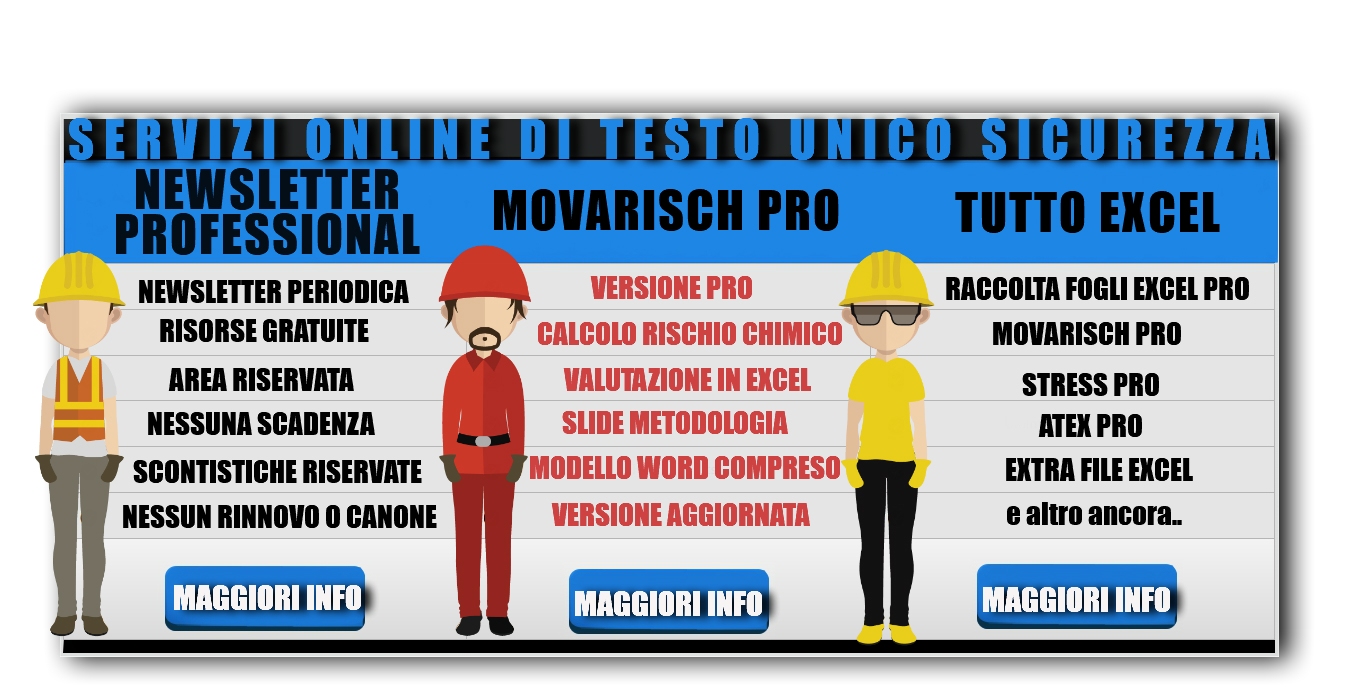Qualità dell'aria interna negli ambienti di lavoro
Qualità dell'aria interna e sindrome dell'edificio malato
Nei luoghi di lavoro, l'aria può essere inquinata da agenti chimici o biologici provenienti da persone, materiali da costruzione o mobili, oggetti decorativi, oggetti immagazzinati in grandi quantità o dall'esterno. Il concetto di "qualità dell'aria interna (IAQ)" viene utilizzato per descrivere l'atmosfera dei locali in cui l'inquinamento non è direttamente correlato a una specifica attività professionale come l'uso di sostanze chimiche o l'implementazione di processi.
All'interno degli edifici, l'esposizione delle persone a più sostanze chimiche o microrganismi come la muffa, anche a basse dosi, può influire sulle condizioni di lavoro e portare a rischi cronici per la salute per lunghi periodi di tempo.
Una buona qualità dell'aria sul posto di lavoro richiede:
scegliere materiali il più possibile a bassa emissività durante la costruzione di edifici o la ristrutturazione di locali;
ricercare ed eliminare possibili fonti di umidità;
garantire un'efficace ventilazione dell'edificio, ovvero sufficienti apporti di aria esterna in relazione al numero di occupanti e ben distribuiti nei diversi ambienti;
garantire che l'aria immessa nell'edificio sia pulita in caso di ambiente esterno fortemente inquinato;
garantire la corretta manutenzione dell'impianto di ventilazione al fine di mantenerne le prestazioni nel tempo.
In alcuni locali, l'inquinamento atmosferico è legato alla presenza umana (vapore acqueo, anidride carbonica, ecc.) nonché all'emissione di composti chimici e biologici da:
l'ambiente interno (materiali per l'edilizia e la decorazione, mobili, prodotti per la pulizia, riscaldamento, condizionamento dell'aria e attrezzature per ufficio, nonché prodotti immagazzinati in particolare nei locali di vendita e stoccaggio);
l'ambiente esterno (inquinanti provenienti dal traffico stradale o dall'attività industriale o agricola, ad esempio, o di origine naturale, come il polline), e anche attraverso il suolo con il radon, un gas radioattivo.
Gli inquinanti chimici sono principalmente composti organici volatili (aldeidi, composti aromatici, terpeni, ecc.) o composti semivolatili (ftalati, alchilfenoli, eteri di difenile polibromurato, ecc.), ma anche aerosol che possono veicolare agenti chimici pericolosi (amianto, piombo, ecc.) e microrganismi (batteri, virus, muffe, ecc.). Il radon, un gas radioattivo presente in natura, viene emesso principalmente dal suolo in alcune regioni e può essere presente in concentrazioni significative in locali situati nel sottosuolo o al piano terra
Effetti sulla salute
Una scarsa qualità dell'aria interna può avere effetti sulla salute che possono essere acuti, a breve o lungo termine.
Possono essere osservati effetti acuti in caso di guasto grave di un dispositivo o del sistema di ventilazione. Questi possono esseremal di testa, nausea, irritazione delle mucose. Un avvelenamento da monossido di carbonio grave o addirittura fatale può verificarsi anche in seguito all'uso di riscaldatori a combustione difettosi.
Gli effetti a breve termine possono essere malattie infettive trasmesse per via aerea come l'influenza
Gli effetti a breve termine includono la sindrome dell'edificio malato. Questa sindrome comprende vari effetti non specifici sulla salute che si verificano negli occupanti di un edificio. La scarsa qualità dell'aria interna è solo una delle possibili cause di questa sindrome, che può essere causata anche da fattori legati alla qualità dell'ambiente di lavoro (livello di rumore, illuminazione e comfort termico, lavoro su schermi, ecc.) e psicologici (lavoro poco motivante, impossibilità di aprire le finestre, ecc.).
Sindrome Dell’edificio Malato: Che Cos’è E Come Si Combatte?
La Sindrome dell'edificio malato (Sick building syndrome - SBS) indica un quadro sintomatologico ben definito, che si manifesta in un elevato numero di occupanti edifici moderni o recentemente rinnovati, dotati di impianti di ventilazione meccanica e di condizionamento d'aria globale (senza immissione di aria fresca dall'esterno) e adibiti a uffici, scuole, ospedali, case per anziani, abitazioni civili.
Le manifestazioni cliniche sono aspecifiche, insorgono dopo alcune ore di permanenza in un determinato edificio e si risolvono in genere rapidamente, nel corso di qualche ora o di qualche giorno (nel caso dei sintomi cutanei) dopo l'uscita dall'edificio.
Sebbene i sintomi siano di modesta entità, i casi di SBS. che si verificano in ambienti lavorativi possono avere un costo più elevato di alcune malattie gravi e a prognosi peggiore, a causa del significativo calo della produttività.
L’eziologia è ancora sconosciuta, probabilmente multifattoriale e variabile da caso a caso. Fattori legati agli edifici, ai sistemi di condizionamento e di ventilazione, ai programmi di manutenzione, al tipo e all'organizzazione del lavoro e fattori personali svolgono certamente un ruolo rilevante.
Da numerose indagini in edifici in cui sono stati segnalati problemi di salute o di comfort è emerso che il problema prevalente (in quasi la metà dei casi) era costituito da una ventilazione inadeguata.
Molti composti chimici presenti nell’aria indoor sono noti o sospettati di causare irritazione o stimolazione dell’apparato sensoriale e possono dare vita a un senso di disagio sensoriale e a altri sintomi comunemente presenti nella cosiddetta SBS. Alcuni studi condotti su uffici e altri edifici ad uso pubblico in diversi paesi, hanno rivelato una frequenza di disturbi tra gli occupanti compresa tra il 15% e il 50%.
In Italia già da molti anni sono riportati episodi significativi, ma non sono stati eseguiti studi epidemiologici su larga scala che abbiano interessato più edifici. Anche nell’esperienza italiana le alterazioni dei parametri ambientali, sebbene in alcuni casi significative, non sembrano da sole poter giustificare l’elevatissima prevalenza di una sintomatologia così complessa e strettamente correlata con la permanenza negli edifici studiati.
Alcuni studi italiani hanno focalizzato l’attenzione sui costi, in termini puramente economici, di episodi di SBS, confermandone l’elevato impatto sociale.
Che cosa si intende per qualità dell’aria interna? La qualità dell’aria interna, detta anche Indoor Air Quality (IAQ) fa riferimento all’aria che respiriamo negli ambienti confinati (di questa categoria non fanno parte gli ambienti di tipo industriale).
Il tema dell’inquinamento indoor è particolarmente complesso e importante, soprattutto perché oggi trascorriamo gran parte delle nostre giornate in spazi chiusi e perché questi, per ridurre le dispersioni termiche e assicurare un maggiore risparmio energetico, sono sempre più “ermetici”.
La Sindrome dell’edificio malato non è l’unica condizione collegata a una scarsa qualità dell’aria indoor. Ad essa, infatti, sono anche connesse la Building-related illness (BRI), ovvero le malattie associate agli edifici, e la Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS), ovvero la Sindrome da sensibilità chimica multipla.
Passando alle cause scatenanti, queste non sono ancora ben chiare; più probabilmente, sono multifattoriali e variabili caso per caso. Tra gli elementi che potrebbero influenzare l’insorgere della sindrome c’è una scarsa ventilazione dei locali (elemento fondamentale per garantire una buona qualità dell’aria interna), la presenza di contaminanti chimici, ad esempio composti volatili emessi da elementi di arredo, di costruzione oppure da detergenti e fumo di tabacco, e di contaminanti biologici come virus, batteri, pollini e muffe.
Anche altri aspetti possono influire, per esempio inadeguati livelli di temperatura, umidità e illuminazione, oppure uno stress elevato. Individuare una singola causa è quindi difficile, dato il grande numero di fattori che può provocare questa condizione.
Sick Building Syndrome e tutela della salute dei lavoratori
L’Art. 2087 del c.c. obbliga ogni datore di lavoro a tutelare la salute dei suoi dipendenti. Il D. Lgs 81/2008, inoltre, stabilisce una serie di procedure per prevenire malattie ed infortuni sul lavoro, compresi i danni da esposizione ad agenti biologici.
In questo impianto normativo si inserisce anche la Sindrome da Edificio Malato, che è a tutti gli effetti un quadro clinico causato dal mancato rispetto delle norme di tutela della salute del lavoratore.
Detto in soldoni, NON provvedere alla salubrità degli ambienti di lavoro espone il datore di lavoro o chi opera in sua vece a possibili denunce da parte dei dipendenti o delle rappresentanze sindacali. Con le conseguenze legali e penali che ovviamente ne possono derivare e i dovuti esborsi di denaro per il risarcimento dei danni richiesto.
La qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ) si riferisce all’aria interna che si respira negli ambienti confinati, quali:
abitazioni
uffici pubblici e privati
strutture comunitarie (ospedali, scuole, uffici, caserme, alberghi, banche)
ambienti destinati ad attività ricreative e sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive)
mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave, etc).
Gli ambienti di tipo industriale non rientrano nella definizione di ambienti confinati (o indoor) in quanto la qualità dell’aria interna è strettamente correlata al tipo di attività produttiva svolta ed è sottoposta a controlli eleggi specifiche.
L’aria indoor proviene dall’aria atmosferica esterna (outdoor) ed entra negli ambienti confinati attraverso la ventilazione (naturale e/o artificiale).
Negli ambienti chiusi o semichiusi l'ossigeno presente nell’aria (interna) viene gradatamente consumato, mentre con la respirazione e la traspirazione umana sono immessi nell’aria alcuni componenti quali: vapore acqueo, anidride carbonica (CO2) e diverse sostanze organiche.
In assenza di adeguata ventilazione, la qualità dell’aria interna tende ad alterarsi, come conseguenza della presenza e dell’accumulo di sostanze inquinanti: sostanze con caratteristiche tali da modificare la normale composizione o stato fisico dell’aria e alterarne la salubrità (aria viziata). L’"aria viziata" si riconosce istintivamente con l'odorato. L’aria pulita invece non ha odore e non è percepita dagli occupanti.
Con la ventilazione è possibile rinnovare l’aria viziata di un ambiente, sostituendola con aria più pulita e diluire la concentrazione delle sostanze nocive prodotte da fonti interne; inoltre è possibile eliminare anche il vapore acqueo in eccesso. La ventilazione degli ambienti svolge quindi un ruolo importante nel garantire una buona qualità dell’aria interna e l’umidità relativa (o grado igrometrico) fornisce indicazioni utili sulla ventilazione di un ambiente.
Negli edifici caratterizzati da ventilazione naturale, l’aria esterna penetra attraverso aperture esistenti nell’involucro edilizio, come giunti o crepe nei muri, interstizi attorno agli infissi (infiltrazione) e attraverso l’apertura di porte e finestre. L’aria esterna può essere introdotta in un ambiente chiuso attraverso i sistemi di ventilazione meccanica (o forzata) che possono svolgere anche le funzione di riscaldare o raffreddare l’ariainterna, a seconda della stagione (sistemi di termoventilazione).
FONTI E SOSTANZE
Studi scientifici dell’ultimo decennio, condotti da Centri di Ricerca europei, dimostrano che nell’ambiente costruito sono presenti diverse sostanze che possono presentare concentrazioni 10 o 100 volte superiori rispetto a quelle riscontrabili nell’aria esterna. Negli spazi confinati gli inquinanti prodotti all’interno degli edifici si aggiungono a tutte le sostanze che si possono rilevare all’esterno.
L’aria esterna nelle immediate vicinanze dell’edificio, apporta nell’ambiente, il cosiddetto “inquinamento di fondo” generato da traffico, impianti di riscaldamento, industrie e attività artigianali della zona. Ad esso si aggiungono le emissioni prodotte all’interno degli edifici dalle diverse fonti già analizzate. Quindi il fattore umano diviene fondamentale in questo contesto.
Le sostanze inquinanti vengono di solito classificate in tre principali gruppi:
inquinanti di natura fisica: radon, fibre naturali/artificiali, polveri, campi elettromagnetici, ecc.:
inquinanti di natura chimica: composti organici volatili (VOC), monossido e biossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, ecc.;
inquinanti di natura microbiologica: funghi, muffe, pollini, acari, bacilli,ecc.
Concentrandosi sui materiali da costruzione e di arredo si nota come questi influiscono pesantemente sull’inquinamento dell’aria interna. Studi condotti dalla stessa OMS accertano che il 40% del materiale usato nella globalità del settore edilizio può nuocere alla salute.
La direttiva CEE89/106 ha definito i requisiti per i prodotti da costruzione stabilendo che vi debba essere il controllo delle fonti di inquinamento, per eliminare o limitare il rilascio degli inquinanti nell’aria. Nel 1996 il Comité Européen de Normalisation (CEN) ha individuato dei “valori soglia per ambienti” in cui le persone permangono a lungo: essi vengono individuati in funzione della “concentrazione interna accettabile”, ovvero quella concentrazione per cui non si riscontrano effetti negativi sull’uomo.
Tuttavia non è facile individuare questi valori soglia di controllo. Se si considera il controllo e la gestione delle concentrazioni di monossido di carbonio, l’Agenzia Americana per l’Ambiente stabilisce, per tale inquinante, un valore limite pari a 40 mg/m3 per un’ora di esposizione e, per esposizione più prolungate viene portato a 10 mg/m3. Se si pensa che la produzione di monossido di carbonio dovuta al fumo di una sola sigaretta è pari a 50 mg, risulta evidente la difficoltà della gestione delle concentrazioni degli inquinanti.
Inoltre per valutare l’interazione che i materiali da costruzione hanno con la qualità dell’aria interna è necessario considerare tutte le possibili cause ed eventuali interazioni, quali: la messa in opera del materiale, le sue caratteristiche chimico-fisiche, l’influenza dovuta ad altri materiali/sostanze, le condizioni d’uso, il comportamento degli abitanti e il funzionamento degli impianti (Benedetti, 2010).
Nel presente studio ci focalizzeremo sugli inquinanti di natura chimica, ovvero i VOC, ed in particolare sulla formaldeide.
Uno dei più nutriti gruppi di inquinanti è quello dei composti organici volatili (VOC) una serie di sostanze, naturali o sintetiche, nella cui composizione chimica di natura “organica” si rilevi la presenza di atomi di carbonio. Oltre al carbonio, le molecole di tali sostanze contengono pochi altri elementi quali idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, alogeni e metalli.
Numerosi composti organici si presentano instabili e reattivi a temperatura ambiente, perché già in forma di gas, perché possiedono tempi di decomposizione veloci e possono scindersi in sostanze più o meno nocive, perché possiedono un’alta tensione di vapore in relazione alla temperatura ambiente, oppure perché in grado di provocare, attraverso reazioni chimiche auto-innescanti o in presenza di catalizzatori, rilascio di gas o vapori dai prodotti che ne fanno uso.
Si sottolinea come, tra tutte le sostanze, sia più difficile valutare gli effetti dovuti alle diverse emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) ed altre sostanze chimiche. Numerose sono le documentazioni che associano il rischio della salute con le miscele di VOC. Anche dosi minime di questi composti possono provocare disturbi aspecifici quali: infiammazioni delle mucose, emicrania, spossatezza e malessere. Per questo è essenziale contenere al massimo l’uso e la produzione di sostanze nocive nelle abitazioni riducendo ,così, il manifestarsi di eventuali rischi.
Benzene e derivati
Nonostante l’uso di questa sostanza sia vietato in quasi tutti i Paesi a causa delle gravi conseguenze che provoca per la salute, essa viene regolarmente rinvenuta in quantità preoccupanti da tutte le sperimentazioni finalizzate all’individuazione di sostanze emesse negli ambienti confinati da arredi o materiale da costruzione. La ragione di questa consistente presenza è da ascriversi al fatto che le legislazioni proibiscono la sostanza ma non i suoi composti, che anzi vengono utilizzati in maggiore quantità come sostituti del benzene stesso. Inoltre i provvedimenti di proibizione di questa sostanza sono relativamente recenti, e il largo impiego che ne è stato fatto (in collanti, vernici, prodotti per la pulizia della casa, ecc.), fa sì che esistano ancora tracce di benzene in molti elementi di arredo e di finitura interna di fattura non recente.
Le cause principali della presenza di benzene negli ambienti confinati sono il fumo di sigaretta, le colle, le vernici, i prodotti di manutenzione e di pulizia del legno e della casa in generale, ma anche l’acqua e i cibi. Molti composti sono anche cancerogeni per l’uomo e comportano, oltre a manifestazioni acute, conseguenze croniche all’esposizione prolungata a bassi dosaggi.
Pentaclorofenolo (PCP)
Questa sostanza, e le sostanze da essa derivate, utilizzata negli insetticidi ha una larghissimo utilizzo, per le sue caratteristiche di “biocida universale”, principalmente come conservante del legno e come antimuffa per le vernici, ma anche per la concia delle pelli e la produzione di tessuti e prodotti per il bricolage.
La pericolosità di questa sostanza è anche legata al fatto che la sua diffusione all’interno del corpo umano avviene in tempi molto rapidi con una concentrazione massima nel sangue, nel fegato e nei reni. A ciò si aggiunge il fatto che l’esposizione cronica al PCP sembra inibire i meccanismi di smaltimento, e quindi diminuire la velocità di eliminazione della sostanza dal nostro organismo. La continua esposizione può quindi innescare un processo di accumulo nell’organismo, aumentando il grado di intossicazione.
Terpeni
Questa famiglia di composti è presente in grosse quantità nel legno e nei prodotti vernicianti, e raggruppa numerose sostanze meglio note come olii essenziali in quanto esistono in natura come sostanze prodotte dalle piante, alle quali conferiscono un particolare profumo per ogni specie legnosa. La loro presenza nelle emissioni in ambienti confinati non è quindi dovuta solo al loro utilizzo per profumare le cere e i prodotti per la manutenzione del legno e per la pulizia della casa in genere, ma anche al fatto che sono sostanze di cui normalmente il legno è intriso, che non sono eliminate completamente da trattamenti che ne precedono la posa in opera. Le maggiori fonti di emissione di questi VOC sono i serramenti, i pannelli e i mobili in essenza di pino, il legno che più di ogni altro contiene terpeni.
Potrebbe sembrare paradossale paragonare i terpeni agli altri VOC citati in precedenza poiché essi sono noti per le loro proprietà antisettiche e benefiche per la salute. Infatti molti di essi vengono impiegati in profumeria e in farmacia per la preparazione di espettoranti, disinfettanti del cavo orale, farmaci diuretici, spasmolitici e sedativi. Tuttavia, la presenza di queste sostanze in forti concentrazioni conferisce loro un’azione tossica provocando ipersensibilità e allergie (sono note le concentrazioni nocive dell’eucaliptolo e del mentolo). La presenza contemporanea di terpeni assieme ad altri VOC può ingenerare fenomeni di azione nociva sinergica.
Altri composti organici volatili
Tra le sostanze rinvenute nelle emissioni in ambienti confinati vi sono gli idrocarburi clorurati quali il tricloroetilene e la trielina, che hanno effetti sul sistema nervoso centrale e sul fegato. La gamma dei sintomi varia dalla cefalea, sonnolenza, vertigini alle lesioni epatiche. I clorobenzeni associano a questi effetti anche irritazioni cutanee e cloracne. Un altro composto molto pericoloso è il tetracloruro di carbonio che intacca gravemente il fegato e i reni ed è stato dichiarato cancerogeno. A ciò si aggiunge la famiglia dello stirene e dei suoi derivati che colpisce il fegato producendo alterazioni nella composizione del sangue , oltre a mal di testa, astenia e nausea. Lo stirene è anche mutageno, cioè può provocare mutazioni e alterazioni genetiche. Molti dei possibili effetti di queste sostanze sono ancora sconosciuti; per molte di esse non sono stati ancora condotti studi sugli effetti sull’uomo e nemmeno sono stati previsti valori massimi di utilizzo o di presenza negli spazi confinati.
La formaldeide, nota anche come metanale, è stata scoperta da Wilhelm von Hofmann con Alexander Butlerov nel 1867. Essa ha un breve ciclo di vita in aria a causa della sua decomposizione in aria per poi formare una sostanza tossica. In commercio è trasportata nel mezzo acquoso poiché si scioglie facilmente. Il suo punto di fusione è -92 ° C e il suo punto di ebollizione è di circa 20 ° C. La sua formula chimica è HCHO.
A temperatura ambiente è possibile trovarla in due forme: come soluzione acquosa al 37% o come paraformaldeide. La paraformaldeide può anche essere riconvertita in formaldeide.
La presenza di questa sostanza nel legno è nota da molto tempo, come sono note le sue proprietà intossicanti, oltre a quelle antisettiche e conservanti, per cui viene impiegata. Nel legno essa si presenta sotto forma di resina collante unita all’urea (UFFI: Urea Formaldeide Foam Insulation), a fenoli o alla melammina.
Il suo rilascio negli ambienti confinati è dovuto al fatto che essa è solubile in acqua e che normalmente una parte delle quantità di formaldeide impiegata per a costituzione della resina non si lega stabilmente nella polimerizzazione, ma viene emessa costantemente dal collante. Perciò l’umidità relativa dell’ambiente risulta essere uno dei fattori principali di rilascio, caratterizzante anche i tipi di composti emessi (aldeidi alifatiche o aromatiche e chetoni).
L’emissione di formaldeide è poi determinata dalla temperatura: è dimostrato, infatti, che l’aumento della temperatura ne incrementa in modo quasi iperbolico l’emissione. Poiché la presenza umana negli ambienti confinati provoca un inevitabile incremento di temperatura e dell’umidità relativa per effetto del metabolismo, soprattutto in ambienti affollati, si comprende l’effetto della presenza umana sull’emissione di formaldeide. Infine, l’emissione di questa sostanza diminuisce col tempo, probabilmente perché il legno (o il suo composto) rilascia gran parte dell’umidità assorbita durante le fasi di lavorazione e per un periodo successivo limitato.
È stato calcolato che il periodo di rilascio in seguito all’espulsione dell’umidità residua è in media di due anni e mezzo, dopo di che subentra una fase di rilascio dovuta alla disgregazione del materiale collante instabile, favorita e accelerata dalle impurità presenti nella resina. Questa seconda fase è caratterizzata da una minore intensità di emissione e da tempi di rilascio molto più lunghi.
Questo composto è stato classificato dall’IARC (International Agency for Research on Cancer), sottogruppo dell’OMS per la ricerca sui tumori, come sostanza cancerogena per l’uomo ed è stata inserita tra le sostanze di “categoria 1” ovvero tra gli elementi di cui oggi è nota la cancerogenicità. Purtroppo, ad oggi, in Italia non esistono, a riferimento, dei valori limite di concentrazione di formaldeide per gli ambienti residenziali o comunque non lavorativi, ed è possibile rintracciare solo valori indicativi, che per la specifica sostanza in esame, nella Circolare n. 57/83 del Ministero della Salute, risulta essere di 123 µg/m3, corrispondente a 0,1 ppm. Questa indicazione rappresenta un limite di accettabilità: la fonte, che ne ha permesso la quantificazione, è costituita da studi epidemiologici, ovvero analisi condotte su gruppi di popolazioni esposte rispetto a campioni di persone non esposte. Tali studi non sono, dunque, rappresentativi di un dato assoluto. Questa carenza è dovuta a “target” di riferimento diversi per ogni Paese in conseguenza dei dati epidemiologici derivanti da studi condotti dalle singole nazioni sull’argomento.
Il legno
Il legno è un materiale che contiene diverse sostanze organiche volatili tra cui alfa-pirene, beta-pirene, limonene, ed elementi che fanno parte della categoria degli aldeidi semplici. Queste sostanze possono non risultare pericolose per una persona in buona salute ma possono avere anche effetti benefici poichè stimolano la circolazione,. Quando il legno subisce dei trattamenti che comportano il suo riscaldamento si vengono a generare aldeidi complessi: nonanale, exanale, ecc.. Essi possono risultare tossici tanto per i soggetti allergici quanto per le persone sane.
Un’attenzione particolare meritano dunque sostanze quali: benzolo, toluene, etilbenzolo, m/p-xilene, limonene, carene e formaldeide. Sono tutti elementi rintracciabili nelle colle, nei solventi e in alcune cere utilizzate per trattare elementi lignei.
Per tutte le sostanze elencate precedentemente non esistono valori limite ma ogni nazione ha cercato di individuare e valutare propri valori soglia accettabili.
a diminuzione della concentrazione e della vigilanza sul lavoro può anche essere correlata all'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica nell'aria causato da una ventilazione insufficiente.
Sulla base di studi epidemiologici condotti sulla popolazione generale, a lungo termine, la scarsa qualità dell'aria può contribuire all'insorgenza di malattie di origine multifattoriale come l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), i tumori e gli eventi cardiovascolari.
Ridurre al minimo le emissioni inquinanti all'interno dell'edificio
Consiste principalmente nella scelta di materiali da costruzione, decorativi e d'arredo che emettano il minor numero possibile di composti organici volatili (COV). Ciò è facilitato dalle normative che richiedono che i materiali da costruzione e decorazione siano etichettati in base ai loro livelli di emissione.
Eliminare le fonti di umidità
L'umidità favorisce lo sviluppo di microrganismi altamente dannosi per la qualità dell'aria. Negli edifici, soprattutto quelli vecchi, si tratta di individuare tutte le fonti di umidità, sia che provengano da perdite nelle reti idriche o di riscaldamento sia che provengano da infiltrazioni dal tetto o dalle pareti esterne.
Ventilare a sufficienza per rimuovere le emissioni delle persone (vapore acqueo e anidride carbonica) e dei materiali e delle attrezzature
Un apporto d'aria fresca di almeno 50 m3/h per occupante è richiesto negli spazi di lavoro terziari, con particolare attenzione alla ventilazione meccanica centralizzata. L'obiettivo è limitare l'aumento della concentrazione di CO2 rispetto all'aria esterna ad un massimo di 400 ppm (parti per milione).
Proteggere l'ambiente interno dall'inquinamento esterno
In ambienti esterni inquinati (in prossimità di una strada con traffico stradale intenso, siti industriali, ecc.), la ventilazione meccanica centralizzata facilita l'installazione di un sistema di filtrazione dell'aria proveniente dall'esterno per ridurre la concentrazione di particelle. Nel caso di specifici inquinanti gassosi presenti nell'aria esterna, si dovrebbe valutare la possibilità di un'adeguata pulizia, assicurandosi che lo scrubber proposto non formi composti secondari tossici.
Sintomi non specifici correlati agli edifici
I sintomi correlati agli edifici sono sintomi che si verificano in associazione con uno specifico ambiente interno, ma non sono facilmente classificati come una singola malattia definibile. Il termine sindrome dell'edificio malato è stato usato per riferirsi a malattie che si verificano in gruppi all'interno di un edificio, ma questo termine è sempre più sostituito da quello di sintomi correlati agli edifici.
I sintomi comunemente riportati correlati agli edifici comprendono
Prurito, irritazione, secchezza oculari o lacrimazione
Rinorrea o congestione nasale
Dolore o fastidio alla gola
Tosse e congestione toracica
Dermatosi pruriginose o inspiegabili eruzioni cutanee
Cefalea, letargia e difficoltà di concentrazione
I sintomi di cui sopra devono indurre a considerare la possibilità di un'esposizione ambientale interna.
Diagnosi delle malattie correlate agli edifici
Valutazione dei fattori del paziente
Valutazione del posto di lavoro
Valutazione del paziente
La diagnosi di malattia correlata all'edilizia si basa sull'anamnesi dell'esposizione e sui reperti clinici (compresi insorgenza dei sintomi, tempistica e progressione). Deve essere documentato un maggiore uso di farmaci, visite mediche e giorni di malattia.
I sintomi associati temporalmente con uno specifico edificio o ambiente e che migliorano quando il paziente è lontano dall'ambiente sono un indizio importante che deve essere notato. Come in qualsiasi altro incontro clinico, devono essere escluse malattie specifiche, come l'asma o la polmonite da ipersensibilità. Un'ulteriore valutazione deve essere basata sui sintomi. Per esempio, i test di funzionalità polmonare possono essere istruttivi nei pazienti esposti quando sono sintomatici.
La valutazione dell'esposizione comprende una descrizione del lavoro e degli altri ambienti in cui il paziente frequenta, comprese le dimensioni dello spazio, il numero di lavoratori, la ventilazione, le attività lavorative e le potenziali fonti di esposizione come polvere, sostanze chimiche, gas, prodotti per la pulizia, muffe, e altri agenti microbici. Il paziente deve essere interrogato su eventuali cambiamenti nel posto di lavoro o processi di lavoro che possono coincidere con l'insorgenza o l'esacerbazione dei sintomi. Sintomi simili in altri occupanti dell'edificio, anche se non sempre presenti, possono essere un indizio di malattia correlata all'edificio.
Le strutture abitative più diffuse comprendono uffici, scuole, ristoranti, luoghi di divertimento e strutture sanitarie. Recenti lavori di restauro, rinnovazione o costruzione devono essere documentati e valutati come una potenziale fonte di esposizione.
Valutazione del posto di lavoro
Una valutazione sul posto di lavoro può essere utile per identificare i fattori che contribuiscono alla malattia o ai sintomi correlati all'edificio. Una valutazione sul posto di lavoro aiuta a identificare potenziali esposizioni, come incursione di acqua, muffe, polvere, odori e temperature estreme, così come per avere una informazione sulla qualità ambientale interna complessiva, compresa la ventilazione e l'immissione di aria pulita. Fonti di informazioni sull'ambiente interno comprendono il datore di lavoro, le precedenti valutazioni del posto di lavoro, le schede di sicurezza, i precedenti rapporti di monitoraggio ambientale, e i rappresentanti dei sindacati.
Un ampio campionamento di aria e superficie, come per la muffa, non è generalmente necessario ed è spesso costoso. La maggior parte delle malattie correlate agli edifici è legata a più di un'esposizione combinata con una ventilazione inadeguata
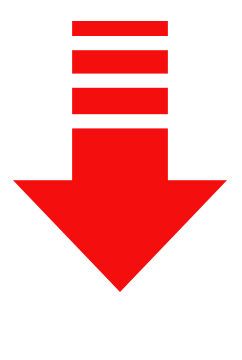
|
MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL: Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.
Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di
ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.
L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi. |
NEWSLETTER PROFESSIONAL

Sei gia' iscritto alla nostra Newsletter Professional?
Inserisci l'email con cui ricevi le news Periodiche per procedere con il download.Se non sei ancora iscritto scopri come farlo cliccando sul pulsante Maggiori Info..
Maggiori Info sulla Newsletter Professional